Francesca Serafini, nient’altro che le parole

Tempo stimato per la lettura: 11 minuti
Forse l’avrete capito, ma ci siamo letteralmente innamorati dell’ultimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo. La forza, l’onestà e il coraggio di questa storia ci ha spinto a ricercare i protagonisti del racconto, dopo Matteo Graia, abbiamo conversato con Francesca Serafini che, insieme a Caligari e Giordano Meacci, ha scritto la sceneggiatura del film.
A scuola ti immagino come l’alunna preferita della prof. d’italiano, quella che leggeva il proprio tema a voce alta, facendo vergognare i compagni. Eri così?
Mi impressiona la tua domanda, perché non ci conosciamo ma è andata proprio (più o meno) così. Non credo di aver mai fatto vergognare nessuno: anche perché sono sempre stata indisciplinata e con gli altri ho fatto sempre gruppo; e poi ero una che “passava”, sicché, se pure è successo, nessuno aveva interesse a farmelo capire. Però c’è una cosa di cui sono io che mi vergogno, ora che mi hai sollecitato il ricordo. Una volta alle medie la mia insegnante decide di far leggere un tema alla preside (tra l’altro una preside speciale: quella che aveva accolto Pasolini a Ciampino dopo i fatti di Ramuscello e che Giordano Meacci ricorda in Improvviso il Novecento – Pasolini professore), ma dice anche – cosa verissima – che la mia grafia è incomprensibile. E dunque chiede a una mia compagna di ricopiare tutto “in bella”. Io lo prendo come un affronto e, nonostante i complimenti della preside per quello che avevo scritto, vivo quella circostanza con imbarazzo e una punta d’indignazione. Oggi, ripensandoci, mi rendo conto che avrei dovuto trarre una lezione dall’umiltà della mia compagna, felice di mettere la sua calligrafia al servizio delle mie parole senza farla troppo lunga.
Da qualche parte, in fondo a un cassetto o sotto il letto, conservi ancora i tuoi primi esperimenti letterari? Io di recente ho trovato un racconto di quando avevo 10 anni su un’albicocca parlante, ad esempio, e non era affatto male.
Conservo tutto: quintali di materiali di tutti i tipi, tranne versi. Non ho mai scritto poesie. Fin da piccola sono stata attratta dalla prosa (creativa e argomentativa) o dal dialogo. A volte mi capita di ricordarmi di qualcosa che avevo scritto e che mi torna utile in quel momento e la uso. È successo per esempio quando lavoravo al saggio su David Mamet che poi è finito nei Tre usi del coltello. Lì ho recuperato un passaggio sulle Relazioni pericolose di Laclos che avevo scritto ai tempi del liceo e che mi sembrava perfetto per la circostanza.
“Le parole sono importanti” diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa, e lo è anche la punteggiatura. Perché hai deciso di scrivere un libro come Questo è il punto?
Perché, a parte le parole, come ricorda Carver, i punti e le virgole sono tutto quello che abbiamo per scrivere. E quindi è fondamentale conoscerli bene. Le idee, i temi, i contenuti, sono più o meno gli stessi (neanche tanti, peraltro) dacché si è cominciato a raccontare storie. Il lavoro che uno scrittore deve fare è quasi esclusivamente sulla forma (non solo la lingua, certo: struttura narrativa e ideazione dei personaggi sono elementi determinanti). E questa cosa mi è stata chiara subito, fin da ragazzina. Sapevo due cose: che non desideravo nient’altro che scrivere; e che per farlo bene era necessario conoscere la lingua in modo da poterne sfruttare tutte le potenzialità.
Da brava linguista ti definiresti una grammar nazi?
No (del resto, neanche l’amore per l’italiano mi farebbe aderire a qualcosa che contenga la parola nazi). La prima cosa che impari quando approfondisci lo studio della lingua è che non esistono certezze, o ne esistono molto poche (e variano anche in base al contesto comunicativo). La lingua è in continua evoluzione e i grammatici ne prendono atto. Quindi paradossalmente sono i più elastici nel valutarne le mutazioni. Il comune senso della lingua è più integralista di quello specifico e competente dei linguisti. Questo naturalmente non significa accettare passivamente ogni moda. Non significa cioè che non continuerò a infastidirmi per ogni “piuttosto che” usato in funzione disgiuntiva anziché comparativa: mi fa un po’ lo stesso effetto di chi beve il caffè sollevando il mignolo dalla tazzina.
Scrivere un libro è cosa ben diversa da scrivere per il cinema, dove la sceneggiatura è solo uno degli elementi, anche se importante. Quanto viene sacrificato sul set del tuo lavoro?
Le differenze sono molte: per esempio, da un punto di vista tecnico, sai che un libro si gioca tutto sulla lingua (intesa proprio come linguaggio); una sceneggiatura deve tenere conto di più codici (ci sono le immagini, naturalmente). Poi il lavoro è organizzato in modo molto diverso, perché quando scrivi per un film ti metti già al servizio delle altre componenti della filiera produttiva che lo porteranno a termine. Ogni esperienza, certo, è diversa dalle altre, perché dipende sempre dai compagni di viaggio. Però, il fatto stesso che per il cinema (o per la tv) non si scrive mai (o quasi mai) da soli aiuta fin dal principio ad avere un atteggiamento di apertura sulle evoluzioni che il tuo contributo potrebbe avere. Anche perché la sceneggiatura è importante, ma per la riuscita completa di un film conta allo stesso modo l’assistente scenografo che deve far trovare gli oggetti giusti in scena o l’acconciatore (per citare ruoli magari meno in risalto nei titoli ma ugualmente decisivi). I film che restano sono quelli in cui si riesce a trovare armonia tra le persone che ci lavorano e che alle proprie smanie narcisistiche antepongono la consapevolezza di lavorare a un’opera collettiva di cui tutti poi potranno sentirsi orgogliosi. Come nel caso di Non essere cattivo, che da questo punto di vista rappresenta un miracolo.
Inevitabile chiedertelo: com’è stato lavorare con Claudio Caligari? Ci racconti il vostro primo incontro?
Lavorare con Claudio è stato un privilegio. Abbiamo condiviso, ancora prima che un lavoro, un’idea di cinema, di arte, di sguardo su quello che ci circonda. D’altra parte con Giordano Meacci abbiamo formato il nostro anche sugli altri due film di Caligari che sapevamo a memoria ancora prima di conoscerlo di persona. Poi quel giorno è arrivato. Lui ci aveva fatto leggere alcune pagine dell’idea e della storia che intendeva sviluppare in Non essere cattivo. E noi gli avevamo risposto con una lunga lettera in cui, già innamorati di Cesare e di Vittorio, proponevamo alcune ipotesi di sviluppo. Quando ci siamo incontrati, appunto, non sapevamo che cosa aveva pensato di quelle riflessioni. E dunque eravamo molto emozionati e anche un po’ spaventati, data anche la nomina di burbero che Claudio si portava dietro. Noi in realtà ci ritrovammo con un uomo dolcissimo, intelligente, ironico: coltissimo (e guarda che non sono una che distribuisce superlativi con facilità). Parlammo per un paio d’ore di Pasolini, di Ferreri, di Fellini; molto, moltissimo, di Scorsese. A un certo punto Claudio comincia a dare i compiti e a dettare le scadenze. Io e Giordano evitiamo di guardarci: prendiamo nota delle date e lo salutiamo. Poi, rimasti soli, abbiamo continuato a ripeterci, increduli e frastornati: “ma dunque lo scriviamo noi? Abbiamo capito bene?”
In Non essere cattivo c’è così tanta vita che sembra di guardare un film neorealista. Non sarà stata così tanta onestà a terrorizzare i produttori italiani?
Temo che Claudio non sarebbe stato d’accordo sulla definizione di neorealista. E forse neanch’io: il fatto che il film risulti autentico, che mostri la realtà senza patine anestetizzanti, è l’effetto; e quello sì, per il suo realismo, è riconducibile a certi film del passato. Non essere cattivo è un film molto lavorato: molto scritto, molto pensato in ogni inquadratura nella regia; nell’interpretazione. Il nostro lavoro è stato quello di nasconderci fino quasi a scomparire, tranne in un paio di occasioni in cui intenzionalmente il Maestro voleva creare una crepa: uno straniamento brechtiano per parlare direttamente con lo spettatore e ricordare a tutti che il cinema è finzione. Un lavoro continuo sulla forma, insomma. E la forma, quando diventa arte, produce sempre un effetto perturbante. Che poi è quello che Claudio è riuscito a fare in tutti i suoi film ma è anche il motivo per cui è stato poco valorizzato dall’industria dell’intrattenimento. Anche se poi i suoi film sono pieni di ritmo e fanno divertire e commuovere, e non hanno niente dell’intellettualismo del cinema che si autopone come di nicchia, tant’è che non si fa scrupoli a sfruttare le potenzialità del genere, come nell’Odore della notte.
Agli ultimi David di Donatello, nonostante le numerose candidature, il film è stato praticamente snobbato, e nessuno ha ricordato Caligari. In direzione ostinata e contraria sempre, no?
In molti hanno detto e scritto che Claudio avrebbe preferito così, per la sua fama di outsider, ma io sono convinta del contrario. Claudio non era un artista di nicchia e non voleva esserlo (l’ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo). I suoi film nel tempo hanno emozionato molte persone e continueranno a farlo. Perché un artista non scrive per sé: non se ne fa niente dell’autocompiacimento. Vuole essere riconosciuto quando ha delle cose da dire e le sa dire così bene. Avrebbe accettato il verdetto della giuria senza pensare a complotti ma certamente non lo avrebbe condiviso, perché era molto consapevole del suo cinema. Avrebbe pensato di meritare di vincere, ma si sarebbe dispiaciuto ancora di più per il mancato riconoscimento di tutto l’amore la dedizione l’ostinazione di Valerio Mastandrea che, nonostante le difficoltà e con molte rinunce personali, era riuscito a rimetterlo sul set; e quello ai suoi due ragazzi, Borghi e Marinelli: due attori, ne sono certa, che anche grazie agli insegnamenti del Maestro regaleranno in futuro altre emozioni al nostro cinema.
L’altra sera un amico mi ha chiesto di spiegargli cos’è e chi sono la Banda Caligari, di cui ha letto sui social. Giro la domanda a te (così faccio anche bella figura!)
Un gruppo di artisti che Caligari ha scelto per lavorare insieme e che lavorando insieme sono diventati amici. Un gruppo di persone che si stimano e che si vogliono bene. E anche di questo dobbiamo essere grati a Claudio: dell’idea che l’amore che puoi mettere nel tuo lavoro può diventare amore anche per le persone con cui lo condividi.
Hai scritto che per tutto il tempo della lavorazione di Non essere cattivo, e anche dopo, i personaggi di Cesare e Vittorio abitavano in te, come nel resto della Banda, ma che ad un certo punto è stato necessario allontanarsene. Ci sei riuscita? E come hai fatto?
Credo che continueranno ad abitarmi finché continuerò a scrivere. Ma non è detto che sia un male. Certo ho dovuto prendere una distanza per riuscire a muovere e a far parlare in modo molto diverso da loro personaggi che non li riguardavano affatto. Però, ogni volta che mi tornano in mente, mi ricordano due cose: che i personaggi non vanno mai giudicati (e quindi vanno raccontati tutti, senza la paura di sporcarli); e che devono avere tante sfaccettature perché prendano vita davvero e non prevalga la loro funzione narrativa.
Sei anche consulente per le fiction per RSI, confessa quante serie tv guardi?
Con Rsi collaboro da diversi anni. E grazie alla fiducia di Gabriella De Gara e di Walter Bortolotti ho tenuto un corso proprio sulla serialità e ora sto coordinando lo sviluppo di uno dei progetti degli allievi. Quanto alle serie che vedo, sono moltissime. In alcuni casi mi fermo al pilota, quando non riescono ad agganciarmi. In altri casi vado fino in fondo: le serie inglesi sono le mie preferite e ultimamente ho molto amato Happy Valley. Per riuscire a dedicarmi a tutte queste cose – senza togliere tempo alla scrittura, alla lettura; alla famiglia – faccio come il Che raccontato da Sartre (che però forse citava Pascal, ma vabbè): “è necessario non dormire”.
condividi su
Francesca Serafini, nient’altro che le parole
Tempo stimato per la lettura: 33 minuti
Forse l’avrete capito, ma ci siamo letteralmente innamorati dell’ultimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo. La forza, l’onestà e il coraggio di questa storia ci ha spinto a ricercare i protagonisti del racconto, dopo Matteo Graia, abbiamo conversato con Francesca Serafini che, insieme a Caligari e Giordano Meacci, ha scritto la sceneggiatura del film.
A scuola ti immagino come l’alunna preferita della prof. d’italiano, quella che leggeva il proprio tema a voce alta, facendo vergognare i compagni. Eri così?
Mi impressiona la tua domanda, perché non ci conosciamo ma è andata proprio (più o meno) così. Non credo di aver mai fatto vergognare nessuno: anche perché sono sempre stata indisciplinata e con gli altri ho fatto sempre gruppo; e poi ero una che “passava”, sicché, se pure è successo, nessuno aveva interesse a farmelo capire. Però c’è una cosa di cui sono io che mi vergogno, ora che mi hai sollecitato il ricordo. Una volta alle medie la mia insegnante decide di far leggere un tema alla preside (tra l’altro una preside speciale: quella che aveva accolto Pasolini a Ciampino dopo i fatti di Ramuscello e che Giordano Meacci ricorda in Improvviso il Novecento – Pasolini professore), ma dice anche – cosa verissima – che la mia grafia è incomprensibile. E dunque chiede a una mia compagna di ricopiare tutto “in bella”. Io lo prendo come un affronto e, nonostante i complimenti della preside per quello che avevo scritto, vivo quella circostanza con imbarazzo e una punta d’indignazione. Oggi, ripensandoci, mi rendo conto che avrei dovuto trarre una lezione dall’umiltà della mia compagna, felice di mettere la sua calligrafia al servizio delle mie parole senza farla troppo lunga.
Da qualche parte, in fondo a un cassetto o sotto il letto, conservi ancora i tuoi primi esperimenti letterari? Io di recente ho trovato un racconto di quando avevo 10 anni su un’albicocca parlante, ad esempio, e non era affatto male.
Conservo tutto: quintali di materiali di tutti i tipi, tranne versi. Non ho mai scritto poesie. Fin da piccola sono stata attratta dalla prosa (creativa e argomentativa) o dal dialogo. A volte mi capita di ricordarmi di qualcosa che avevo scritto e che mi torna utile in quel momento e la uso. È successo per esempio quando lavoravo al saggio su David Mamet che poi è finito nei Tre usi del coltello. Lì ho recuperato un passaggio sulle Relazioni pericolose di Laclos che avevo scritto ai tempi del liceo e che mi sembrava perfetto per la circostanza.
“Le parole sono importanti” diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa, e lo è anche la punteggiatura. Perché hai deciso di scrivere un libro come Questo è il punto?
Perché, a parte le parole, come ricorda Carver, i punti e le virgole sono tutto quello che abbiamo per scrivere. E quindi è fondamentale conoscerli bene. Le idee, i temi, i contenuti, sono più o meno gli stessi (neanche tanti, peraltro) dacché si è cominciato a raccontare storie. Il lavoro che uno scrittore deve fare è quasi esclusivamente sulla forma (non solo la lingua, certo: struttura narrativa e ideazione dei personaggi sono elementi determinanti). E questa cosa mi è stata chiara subito, fin da ragazzina. Sapevo due cose: che non desideravo nient’altro che scrivere; e che per farlo bene era necessario conoscere la lingua in modo da poterne sfruttare tutte le potenzialità.
Da brava linguista ti definiresti una grammar nazi?
No (del resto, neanche l’amore per l’italiano mi farebbe aderire a qualcosa che contenga la parola nazi). La prima cosa che impari quando approfondisci lo studio della lingua è che non esistono certezze, o ne esistono molto poche (e variano anche in base al contesto comunicativo). La lingua è in continua evoluzione e i grammatici ne prendono atto. Quindi paradossalmente sono i più elastici nel valutarne le mutazioni. Il comune senso della lingua è più integralista di quello specifico e competente dei linguisti. Questo naturalmente non significa accettare passivamente ogni moda. Non significa cioè che non continuerò a infastidirmi per ogni “piuttosto che” usato in funzione disgiuntiva anziché comparativa: mi fa un po’ lo stesso effetto di chi beve il caffè sollevando il mignolo dalla tazzina.
Scrivere un libro è cosa ben diversa da scrivere per il cinema, dove la sceneggiatura è solo uno degli elementi, anche se importante. Quanto viene sacrificato sul set del tuo lavoro?
Le differenze sono molte: per esempio, da un punto di vista tecnico, sai che un libro si gioca tutto sulla lingua (intesa proprio come linguaggio); una sceneggiatura deve tenere conto di più codici (ci sono le immagini, naturalmente). Poi il lavoro è organizzato in modo molto diverso, perché quando scrivi per un film ti metti già al servizio delle altre componenti della filiera produttiva che lo porteranno a termine. Ogni esperienza, certo, è diversa dalle altre, perché dipende sempre dai compagni di viaggio. Però, il fatto stesso che per il cinema (o per la tv) non si scrive mai (o quasi mai) da soli aiuta fin dal principio ad avere un atteggiamento di apertura sulle evoluzioni che il tuo contributo potrebbe avere. Anche perché la sceneggiatura è importante, ma per la riuscita completa di un film conta allo stesso modo l’assistente scenografo che deve far trovare gli oggetti giusti in scena o l’acconciatore (per citare ruoli magari meno in risalto nei titoli ma ugualmente decisivi). I film che restano sono quelli in cui si riesce a trovare armonia tra le persone che ci lavorano e che alle proprie smanie narcisistiche antepongono la consapevolezza di lavorare a un’opera collettiva di cui tutti poi potranno sentirsi orgogliosi. Come nel caso di Non essere cattivo, che da questo punto di vista rappresenta un miracolo.
Inevitabile chiedertelo: com’è stato lavorare con Claudio Caligari? Ci racconti il vostro primo incontro?
Lavorare con Claudio è stato un privilegio. Abbiamo condiviso, ancora prima che un lavoro, un’idea di cinema, di arte, di sguardo su quello che ci circonda. D’altra parte con Giordano Meacci abbiamo formato il nostro anche sugli altri due film di Caligari che sapevamo a memoria ancora prima di conoscerlo di persona. Poi quel giorno è arrivato. Lui ci aveva fatto leggere alcune pagine dell’idea e della storia che intendeva sviluppare in Non essere cattivo. E noi gli avevamo risposto con una lunga lettera in cui, già innamorati di Cesare e di Vittorio, proponevamo alcune ipotesi di sviluppo. Quando ci siamo incontrati, appunto, non sapevamo che cosa aveva pensato di quelle riflessioni. E dunque eravamo molto emozionati e anche un po’ spaventati, data anche la nomina di burbero che Claudio si portava dietro. Noi in realtà ci ritrovammo con un uomo dolcissimo, intelligente, ironico: coltissimo (e guarda che non sono una che distribuisce superlativi con facilità). Parlammo per un paio d’ore di Pasolini, di Ferreri, di Fellini; molto, moltissimo, di Scorsese. A un certo punto Claudio comincia a dare i compiti e a dettare le scadenze. Io e Giordano evitiamo di guardarci: prendiamo nota delle date e lo salutiamo. Poi, rimasti soli, abbiamo continuato a ripeterci, increduli e frastornati: “ma dunque lo scriviamo noi? Abbiamo capito bene?”
In Non essere cattivo c’è così tanta vita che sembra di guardare un film neorealista. Non sarà stata così tanta onestà a terrorizzare i produttori italiani?
Temo che Claudio non sarebbe stato d’accordo sulla definizione di neorealista. E forse neanch’io: il fatto che il film risulti autentico, che mostri la realtà senza patine anestetizzanti, è l’effetto; e quello sì, per il suo realismo, è riconducibile a certi film del passato. Non essere cattivo è un film molto lavorato: molto scritto, molto pensato in ogni inquadratura nella regia; nell’interpretazione. Il nostro lavoro è stato quello di nasconderci fino quasi a scomparire, tranne in un paio di occasioni in cui intenzionalmente il Maestro voleva creare una crepa: uno straniamento brechtiano per parlare direttamente con lo spettatore e ricordare a tutti che il cinema è finzione. Un lavoro continuo sulla forma, insomma. E la forma, quando diventa arte, produce sempre un effetto perturbante. Che poi è quello che Claudio è riuscito a fare in tutti i suoi film ma è anche il motivo per cui è stato poco valorizzato dall’industria dell’intrattenimento. Anche se poi i suoi film sono pieni di ritmo e fanno divertire e commuovere, e non hanno niente dell’intellettualismo del cinema che si autopone come di nicchia, tant’è che non si fa scrupoli a sfruttare le potenzialità del genere, come nell’Odore della notte.
Agli ultimi David di Donatello, nonostante le numerose candidature, il film è stato praticamente snobbato, e nessuno ha ricordato Caligari. In direzione ostinata e contraria sempre, no?
In molti hanno detto e scritto che Claudio avrebbe preferito così, per la sua fama di outsider, ma io sono convinta del contrario. Claudio non era un artista di nicchia e non voleva esserlo (l’ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo). I suoi film nel tempo hanno emozionato molte persone e continueranno a farlo. Perché un artista non scrive per sé: non se ne fa niente dell’autocompiacimento. Vuole essere riconosciuto quando ha delle cose da dire e le sa dire così bene. Avrebbe accettato il verdetto della giuria senza pensare a complotti ma certamente non lo avrebbe condiviso, perché era molto consapevole del suo cinema. Avrebbe pensato di meritare di vincere, ma si sarebbe dispiaciuto ancora di più per il mancato riconoscimento di tutto l’amore la dedizione l’ostinazione di Valerio Mastandrea che, nonostante le difficoltà e con molte rinunce personali, era riuscito a rimetterlo sul set; e quello ai suoi due ragazzi, Borghi e Marinelli: due attori, ne sono certa, che anche grazie agli insegnamenti del Maestro regaleranno in futuro altre emozioni al nostro cinema.
L’altra sera un amico mi ha chiesto di spiegargli cos’è e chi sono la Banda Caligari, di cui ha letto sui social. Giro la domanda a te (così faccio anche bella figura!)
Un gruppo di artisti che Caligari ha scelto per lavorare insieme e che lavorando insieme sono diventati amici. Un gruppo di persone che si stimano e che si vogliono bene. E anche di questo dobbiamo essere grati a Claudio: dell’idea che l’amore che puoi mettere nel tuo lavoro può diventare amore anche per le persone con cui lo condividi.
Hai scritto che per tutto il tempo della lavorazione di Non essere cattivo, e anche dopo, i personaggi di Cesare e Vittorio abitavano in te, come nel resto della Banda, ma che ad un certo punto è stato necessario allontanarsene. Ci sei riuscita? E come hai fatto?
Credo che continueranno ad abitarmi finché continuerò a scrivere. Ma non è detto che sia un male. Certo ho dovuto prendere una distanza per riuscire a muovere e a far parlare in modo molto diverso da loro personaggi che non li riguardavano affatto. Però, ogni volta che mi tornano in mente, mi ricordano due cose: che i personaggi non vanno mai giudicati (e quindi vanno raccontati tutti, senza la paura di sporcarli); e che devono avere tante sfaccettature perché prendano vita davvero e non prevalga la loro funzione narrativa.
Sei anche consulente per le fiction per RSI, confessa quante serie tv guardi?
Con Rsi collaboro da diversi anni. E grazie alla fiducia di Gabriella De Gara e di Walter Bortolotti ho tenuto un corso proprio sulla serialità e ora sto coordinando lo sviluppo di uno dei progetti degli allievi. Quanto alle serie che vedo, sono moltissime. In alcuni casi mi fermo al pilota, quando non riescono ad agganciarmi. In altri casi vado fino in fondo: le serie inglesi sono le mie preferite e ultimamente ho molto amato Happy Valley. Per riuscire a dedicarmi a tutte queste cose – senza togliere tempo alla scrittura, alla lettura; alla famiglia – faccio come il Che raccontato da Sartre (che però forse citava Pascal, ma vabbè): “è necessario non dormire”.
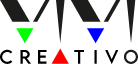








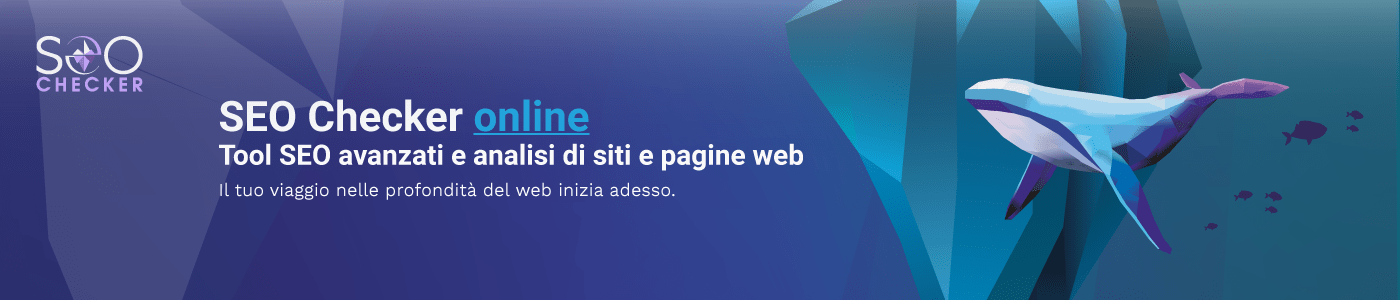
































seguici su