Nicola Guaglianone, di cinema, tv e supereroi di borgata

Tempo stimato per la lettura: 7,1 minuti
Dalla sua prima uscita nelle sale lo scorso febbraio, Lo chiamavano Jeeg Robot continua a fare proseliti e a spiazzare anche i più scettici. E sì anche in Italia si possono fare film sui supereroi senza per forza scimmiottare i prodotti americani. Il piccolo, grande capolavoro di Gabriele Mainetti, tornato nelle sale ad aprile sull’onda del successo agli ultimi David di Donatello, ha molti punti di forza, la regia naturalmente, il talento degli interpreti, ma soprattutto la scrittura, merito di Menotti (al secolo Roberto Marchionni) e Nicola Guaglianone, che abbiamo avuto il privilegio di intervistare.
Nel documentario Un secolo di cinema – Viaggio nel cinema americano di Martin Scorsese il regista riporta una massima dello sceneggiatore Raoul Walsh: “se non hai una storia, non hai niente”. Ma come nasce una storia?
Quando dico che non mangio carne, la risposta di rito è “neanche il pesce?” Quando dico che faccio lo sceneggiatore è “chissà quanta fantasia che hai!”. La fantasia c’entra poco. Per creare una storia serve metodo e immaginazione. Il punto di partenza può essere il più vario. Di solito parto da alcune immagini. Immagini fuori contesto. È questo che mi interessa. Un bambino con la maschera di una tigre al Casilino, una ragazza con il vestito da “principessa” a Tor Bella Monaca. Ma anche i difetti, le psicopatologie, le idiosincrasie. Da qui partono i personaggi, le storie, le paure, le insicurezze, qualcosa di irrisolto. Come i personaggi risolvono i loro problemi è la storia.
C’è un filone nel cinema americano, quello della If Comedy, del “cosa accadrebbe se…”. Ecco, se Nicola Guaglianone fosse cresciuto a Collina Fleming invece che a Villa Bonelli? Magari le tue storie sarebbero incentrate su un gruppo di quarantenni isterici in crisi di identità…
In realtà ho frequentato i Parioli dai 18 ai 25 anni. È stato un momento molto bello della mia vita. Io e il mio amico volevamo fare il “salto sociale”, ma non conoscevamo nessuno. Dopo esserci ripuliti, Adidas Tobacco, Stan Smith, Barbour e camicie a quadretti ci appostavamo a Piazza Ungheria in attesa del cordone di motorini che andava alle feste della Roma bene e li seguivamo. I quarantenni isterici in crisi di identità non mi interessano a meno che non siano vampiri, zombie, ufo o killer.
Anche io come te sono cresciuta con la tv commerciale di Berlusconi, una scorpacciata di merendine e cartoni, manga, telefilm (adoravo i baffi di Magnum P.I.). C’è un programma dei gloriosi anni ’80 che ha determinato la scelta di cosa avresti fatto da grande?
Magnum P.I., che hai nominato. I baffi con il mito intorno. Sono stato alle Hawaii nella villa dove giravano le scene a casa di Higgins. Mi sono commosso. Mi aspettavo che da un momento all’altro uscissero due dobermann ad azzannarmi il culo. Molti altri, partendo da Super Gulp, Bim Bum Bam, Portobello, Fantastico, Telefono Giallo e arrivando a Colpo Grosso e Non è la Rai. La rivoluzione sessuale italiana.
Hai definito Lo chiamavano Jeeg Robot come “l’educazione sentimentale di un misantropo”, io ci vedo anche un Romanzo criminale in chiave supereroistica, che ne pensi?
L’abbiamo sempre pensato come un Pasolini sci-fi. Ma ironicamente. So che Pasolini è come la Madonna e non ci si deve scherzare mai. Poi l’hai detto tu, sono cresciuto a Villa Bonelli, a pochi passi dalla Magliana. La banda era nell’aria.
Guardando il personaggio dello Zingaro, ho pensato immediatamente al Joker di Jack Nicholson e ad una scena in particolare, quella in cui con spray e vernice distrugge (ma forse ricrea) le opere del museo di Gotham. Una scena pop incorniciata da Party Man di Prince che ha la stessa forza e ironia della scena del massacro a casa di Nunzia . Hai pensato a Tim Burton?
La scena di cui parli è stata scritta dopo la prima stesura. Andai a vedere con il mio amico Sergio D’Offizi, storico direttore della fotografia (ti dico solo era operatore alla macchina di Per un pugno di dollari), Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci alla sala Trevi. C’era la scena in cui degli sgherri corcano di botte la Bolkan sulle note di Quei giorni insieme a te. La sera stessa chiamai Roberto e Gabriele e dissi loro “non so dove né perché ma abbiamo bisogno di una scena così”.
Chissà quanto si è arrabbiato Salvatores, quando pubblico e critica hanno definito il vostro film “il primo il primo vero superhero movie italiano”? Ma a parte questo, secondo te, cosa ha reso Jeeg un successo?
Chi ha fatto film splendidi come Turné o Marrakech express credo che non abbia motivi per arrabbiarsi. Tra l’altro lo sai che anni fa scrissi la voce di Salvatores per L’Enciclopedia Treccani? Non esiste la formula del successo. È un mistero. Io ho amato la storia d’amore, i personaggi, la messa in scena, gli attori sono stati tutti bravissimi e Gabriele ha fatto un ottimo lavoro nel trovare un equilibrio in tutti quei generi.
Tempo fa mi sono imbattuta nel corto Due piedi sinistri, bellissimo. L’emarginazione, la diversità, il cambiamento si trovano in qualche modo anche nel lungometraggio Indivisibili di Edoardo de Angelis. Perché hai scelto questi temi?
La diversità mi ha sempre interessato. Dopo il rapporto col mito credo che sarà la mia nuova fissazione. Che poi dovremmo spiegarci meglio cosa intendiamo per “diversità”. C’è una diversità individuale, una rispetto a uno standard che a volte è discutibile (penso agli orientamenti sessuali, alla vecchia e sbagliata idea di razza o al sessismo – c’è un termine di paragone ritenuto erroneamente Giusto e Vero e quello che se ne discosta è diverso nel senso che è sbagliato o inferiore), una diversità che implica abilità fisiche e sociali perdute. Mi interessa osservare come le persone si comportano rispetto a quello che percepiscono come diverso, e in Due piedi sinistri il pregiudizio dello spettatore è uno dei protagonisti della storia.
“L’abitudine per uno scrittore è di consegnare una sceneggiatura e poi scomparire. Questo non fa per me. Io voglio essere coinvolto dall’inizio alla fine” lo diceva Charlie Kaufman in tempi non sospetti, prima dell’avvento di Netflix e della mitologica figura dello showrunner. È così anche per te?
Non sempre. Il set mi annoia. Mi sento a disagio, calpesto cavi, non trovo un posto, la gente mi chiede sempre permesso, e poi mi ringrazia se mi sposto, tutti si conoscono, si vogliono bene. Bisogna lasciar andare quello che scrivi. Anche se con Gabriele mi sento fortunato. Ha molto rispetto per il copione e ritrovo in quello che gira tutto ciò che avevo scritto.
So che stai lavorando alla serie Suburra e che non puoi dirmi nulla. Dimmi almeno se sei uno di quelli che “ok, l’ultimo episodio e poi vado a letto”? Con quale serie hai fatto le ore piccole?
Ero così. Adesso non più. Non sono più bulimico. Ho visto l’alba più con i videogiochi. Ho fatto le notti comunque, anche con serie mediocri (temo che siano quelle che creano più dipendenza). CSI, LOST, Alias. Con le commedie ancora ci casco. Da Seinfeld e Curb your enthusiasm, amori storici che spesso rivedo, a Louie e Episodes.
Il genere salverà il cinema italiano, uccidendo per sempre la moda del filone?
Con Jeeg si è capito che esiste un pubblico che vuole queste storie. Il genere non può avere tutto questo potere salvifico, ma se farà venir voglia di scrivere e girare film, di genere sarà già un buon risultato. Più film si fanno e più è probabile che tra quelli ce ne saranno di molto belli.
condividi su
Nicola Guaglianone, di cinema, tv e supereroi di borgata
Tempo stimato per la lettura: 21 minuti
Dalla sua prima uscita nelle sale lo scorso febbraio, Lo chiamavano Jeeg Robot continua a fare proseliti e a spiazzare anche i più scettici. E sì anche in Italia si possono fare film sui supereroi senza per forza scimmiottare i prodotti americani. Il piccolo, grande capolavoro di Gabriele Mainetti, tornato nelle sale ad aprile sull’onda del successo agli ultimi David di Donatello, ha molti punti di forza, la regia naturalmente, il talento degli interpreti, ma soprattutto la scrittura, merito di Menotti (al secolo Roberto Marchionni) e Nicola Guaglianone, che abbiamo avuto il privilegio di intervistare.
Nel documentario Un secolo di cinema – Viaggio nel cinema americano di Martin Scorsese il regista riporta una massima dello sceneggiatore Raoul Walsh: “se non hai una storia, non hai niente”. Ma come nasce una storia?
Quando dico che non mangio carne, la risposta di rito è “neanche il pesce?” Quando dico che faccio lo sceneggiatore è “chissà quanta fantasia che hai!”. La fantasia c’entra poco. Per creare una storia serve metodo e immaginazione. Il punto di partenza può essere il più vario. Di solito parto da alcune immagini. Immagini fuori contesto. È questo che mi interessa. Un bambino con la maschera di una tigre al Casilino, una ragazza con il vestito da “principessa” a Tor Bella Monaca. Ma anche i difetti, le psicopatologie, le idiosincrasie. Da qui partono i personaggi, le storie, le paure, le insicurezze, qualcosa di irrisolto. Come i personaggi risolvono i loro problemi è la storia.
C’è un filone nel cinema americano, quello della If Comedy, del “cosa accadrebbe se…”. Ecco, se Nicola Guaglianone fosse cresciuto a Collina Fleming invece che a Villa Bonelli? Magari le tue storie sarebbero incentrate su un gruppo di quarantenni isterici in crisi di identità…
In realtà ho frequentato i Parioli dai 18 ai 25 anni. È stato un momento molto bello della mia vita. Io e il mio amico volevamo fare il “salto sociale”, ma non conoscevamo nessuno. Dopo esserci ripuliti, Adidas Tobacco, Stan Smith, Barbour e camicie a quadretti ci appostavamo a Piazza Ungheria in attesa del cordone di motorini che andava alle feste della Roma bene e li seguivamo. I quarantenni isterici in crisi di identità non mi interessano a meno che non siano vampiri, zombie, ufo o killer.
Anche io come te sono cresciuta con la tv commerciale di Berlusconi, una scorpacciata di merendine e cartoni, manga, telefilm (adoravo i baffi di Magnum P.I.). C’è un programma dei gloriosi anni ’80 che ha determinato la scelta di cosa avresti fatto da grande?
Magnum P.I., che hai nominato. I baffi con il mito intorno. Sono stato alle Hawaii nella villa dove giravano le scene a casa di Higgins. Mi sono commosso. Mi aspettavo che da un momento all’altro uscissero due dobermann ad azzannarmi il culo. Molti altri, partendo da Super Gulp, Bim Bum Bam, Portobello, Fantastico, Telefono Giallo e arrivando a Colpo Grosso e Non è la Rai. La rivoluzione sessuale italiana.
Hai definito Lo chiamavano Jeeg Robot come “l’educazione sentimentale di un misantropo”, io ci vedo anche un Romanzo criminale in chiave supereroistica, che ne pensi?
L’abbiamo sempre pensato come un Pasolini sci-fi. Ma ironicamente. So che Pasolini è come la Madonna e non ci si deve scherzare mai. Poi l’hai detto tu, sono cresciuto a Villa Bonelli, a pochi passi dalla Magliana. La banda era nell’aria.
Guardando il personaggio dello Zingaro, ho pensato immediatamente al Joker di Jack Nicholson e ad una scena in particolare, quella in cui con spray e vernice distrugge (ma forse ricrea) le opere del museo di Gotham. Una scena pop incorniciata da Party Man di Prince che ha la stessa forza e ironia della scena del massacro a casa di Nunzia . Hai pensato a Tim Burton?
La scena di cui parli è stata scritta dopo la prima stesura. Andai a vedere con il mio amico Sergio D’Offizi, storico direttore della fotografia (ti dico solo era operatore alla macchina di Per un pugno di dollari), Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci alla sala Trevi. C’era la scena in cui degli sgherri corcano di botte la Bolkan sulle note di Quei giorni insieme a te. La sera stessa chiamai Roberto e Gabriele e dissi loro “non so dove né perché ma abbiamo bisogno di una scena così”.
Chissà quanto si è arrabbiato Salvatores, quando pubblico e critica hanno definito il vostro film “il primo il primo vero superhero movie italiano”? Ma a parte questo, secondo te, cosa ha reso Jeeg un successo?
Chi ha fatto film splendidi come Turné o Marrakech express credo che non abbia motivi per arrabbiarsi. Tra l’altro lo sai che anni fa scrissi la voce di Salvatores per L’Enciclopedia Treccani? Non esiste la formula del successo. È un mistero. Io ho amato la storia d’amore, i personaggi, la messa in scena, gli attori sono stati tutti bravissimi e Gabriele ha fatto un ottimo lavoro nel trovare un equilibrio in tutti quei generi.
Tempo fa mi sono imbattuta nel corto Due piedi sinistri, bellissimo. L’emarginazione, la diversità, il cambiamento si trovano in qualche modo anche nel lungometraggio Indivisibili di Edoardo de Angelis. Perché hai scelto questi temi?
La diversità mi ha sempre interessato. Dopo il rapporto col mito credo che sarà la mia nuova fissazione. Che poi dovremmo spiegarci meglio cosa intendiamo per “diversità”. C’è una diversità individuale, una rispetto a uno standard che a volte è discutibile (penso agli orientamenti sessuali, alla vecchia e sbagliata idea di razza o al sessismo – c’è un termine di paragone ritenuto erroneamente Giusto e Vero e quello che se ne discosta è diverso nel senso che è sbagliato o inferiore), una diversità che implica abilità fisiche e sociali perdute. Mi interessa osservare come le persone si comportano rispetto a quello che percepiscono come diverso, e in Due piedi sinistri il pregiudizio dello spettatore è uno dei protagonisti della storia.
“L’abitudine per uno scrittore è di consegnare una sceneggiatura e poi scomparire. Questo non fa per me. Io voglio essere coinvolto dall’inizio alla fine” lo diceva Charlie Kaufman in tempi non sospetti, prima dell’avvento di Netflix e della mitologica figura dello showrunner. È così anche per te?
Non sempre. Il set mi annoia. Mi sento a disagio, calpesto cavi, non trovo un posto, la gente mi chiede sempre permesso, e poi mi ringrazia se mi sposto, tutti si conoscono, si vogliono bene. Bisogna lasciar andare quello che scrivi. Anche se con Gabriele mi sento fortunato. Ha molto rispetto per il copione e ritrovo in quello che gira tutto ciò che avevo scritto.
So che stai lavorando alla serie Suburra e che non puoi dirmi nulla. Dimmi almeno se sei uno di quelli che “ok, l’ultimo episodio e poi vado a letto”? Con quale serie hai fatto le ore piccole?
Ero così. Adesso non più. Non sono più bulimico. Ho visto l’alba più con i videogiochi. Ho fatto le notti comunque, anche con serie mediocri (temo che siano quelle che creano più dipendenza). CSI, LOST, Alias. Con le commedie ancora ci casco. Da Seinfeld e Curb your enthusiasm, amori storici che spesso rivedo, a Louie e Episodes.
Il genere salverà il cinema italiano, uccidendo per sempre la moda del filone?
Con Jeeg si è capito che esiste un pubblico che vuole queste storie. Il genere non può avere tutto questo potere salvifico, ma se farà venir voglia di scrivere e girare film, di genere sarà già un buon risultato. Più film si fanno e più è probabile che tra quelli ce ne saranno di molto belli.
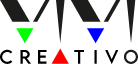









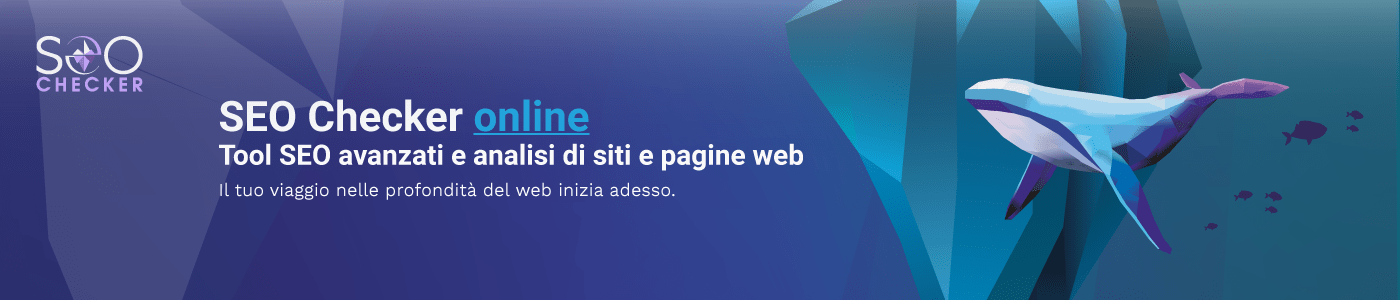
































seguici su